Apprendere il jazz giocando con le macchinine. Ritratto di Samuele Garofoli
Prosegue la rubrica "Ritratti" curata da Enrico Carli

Prosegue la rubrica Ritratti curata da Enrico Carli. Storie di imprenditori, artisti, artigiani e professionisti che hanno un progetto, un’idea per il presente e per il futuro. La città si racconta attraverso le persone che ci vivono e fanno qualcosa, anche di piccolo, perché questa comunità sussista e possa fornire svago, cultura, introiti e il cambiamento di cui abbiamo bisogno in un momento di ricerca verso una società più sostenibile.
Il tuo curriculum, scaricabile sul web, è lungo trentuno pagine e naturalmente è ancora in fieri, dal momento che sei in piena attività. Tra organizzazioni di festival jazz, direzioni artistiche, insegnamento, collaborazioni con celebrati jazzisti e album tuoi e ai quali hai collaborato, mi sembra ci sia un comune denominatore… Che cosa rappresenta per te il jazz?
Innanzitutto è la colonna sonora della mia vita a partire dalla mia infanzia. I dischi di jazz erano in casa – mio padre è un appassionato – e quindi io, anche mio malgrado, lo ascolto fin da bambino, perché non mi piaceva molto inizialmente. Poi ho cominciato ad apprezzare. Lo apprezzavo mentre giocavo. Forse avevo soli cinque anni quando mettevo i primi dischi, i primi LP.
Tu li mettevi? A soli cinque anni?
Sì, perché c’era un brano diArt Farmer che mi piaceva particolarmente, sembrava la sigla di un telefilm poliziesco e quindi io iniziavo i miei giochi con le macchinine proprio con quello (ride). Però lo toglievo quando iniziavano i “soli”, le parti improvvisative. Solo il tema, all’inizio, perché per apprezzare la parte improvvisativa bisogna… non tanto conoscere il jazz, perché alla fine non lo conosce nessuno, bisogna tentare di capire che cosa accade in quel momento. In quel momento c’è un dialogo, un dialogo molto forte… tu ascolti persone che dialogano tra loro, che si fanno delle domande, che fanno degli interventi, e quindi ascoltare un’improvvisazione è come ascoltare un dialogo. E più sono bravi i musicisti più, come dire, questo dialogo funziona.
Non è solo una cosa tecnica. Molte volte il jazzista è colui che sforna cose incredibili lì sul palco, ma alla fine non è quello che funziona. Quello che funziona è la sua capacità di stare a contatto con gli altri, gli altri musicisti, il pubblico, il luogo. In tutta la musica è così, però nel jazz questa cosa è fortissima, è una metodologia diversa da quella che viene fatta da un compositore e poi eseguita… lì c’è una traccia, c’è un canovaccio e una struttura, e poi tutto viene sul momento però non c’è improvvisazione. Questa, paradossalmente, questa forma d’arte qui, viene per il dialogo tra tutti i musicisti e i loro strumenti.
Ed troppo per un bambino di cinque anni?
Troppo per un bambino di cinque anni. Però quando lo capisci è una cosa super affascinante.
E tu quando lo hai capito?
Be’… alcune cose solo ieri sera (il giorno precedente questa intervista ha suonato in un’orchestra al Pescara Jazz). Nel senso che ogni volta si capiscono delle cose. C’è un percorso che… non mi basterà la vita di sicuro, per arrivare lì. Però è un processo che vale per tutta la musica.
Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta hai partecipato ai seminari di Siena Jazz, avendo come maestri Paolo Fresu ed Enrico Rava. Ti va di dirci qualcosa su questa esperienza formativa?
Per me è stata fondamentale, perché io vengo da un piccolo paese, Roncitelli, avevo i dischi in casa ma non avevo nessun contatto con i musicisti oltre mio padre. Avevo però sviluppato una grandissima capacità di adattamento e di improvvisazione perché con un mio amico carissimo ci incontravamo tutti i pomeriggi per suonare. Lui aveva preso appena due lezioni di pianoforte, ma aveva una gran bella manualità. E quindi io gli dicevo alcune cose e lui riusciva a farle in un attimo meglio di me. Questa manualità l’ha portato adesso a fare il chirurgo e ha portato me a fare il musicista, perché quando si suona tutti i giorni con un’altra persona bisogna adattarsi. Quando si sbaglia la struttura, quando si sbaglia un accordo… però tentare di far uscire la musica lo stesso è stato fondamentale. Quindi quando sono arrivato a Siena io ho portato quel bagaglio. Era un bagaglio importantissimo: l’ascolto, fin da bambino, e quella capacità di adattarmi. Due cose fondamentali. La prima edizione con Fresu lui voleva mettermi subito al terzo livello ma io non me la son sentita.
Che si intende con terzo livello?
Terzo livello di capacità jazzistiche e musicali. Però, ripeto, mi son rifiutato, perché avevo solo questa grandissima capacità di… cavarmela. Proprio per la pratica quotidiana e il linguaggio, che era molto chiaro perché lo avevo appreso giocando con le macchinine da bambino.
Tutto nasce lì, eh?
Sì, sì. Lo studio è venuto dopo.
Sei un trombettista. La tromba è uno degli strumenti simbolo del jazz, annovera tra i suoi virtuosi gente del calibro di Luis Armstrong, Miles Davis, Chet Baker, Dizzy Gillespie e molti altri, tra cui i già citati Enrico Rava e Paolo Fresu. Non ti chiederò qual è il tuo trombettista preferito, ma quello che ti fa sentire più incapace.
(Segue un lungo silenzio meditativo). Allora… bella domanda. Nessuno, o anche tutti, dipende da come la si guarda. Da un punto di vista tecnico, tutti. Da un punto di vista musicale nessuno. Non perché io mi senta al loro livello: assolutamente no. È che il jazz ti permette di esprimerti con quello che hai. Ed essere te stesso, anche a fianco di musicisti stratosferici. E… quando sento suonare qualcuno che ammiro tanto, da Paolo Fresu a Rava, due musicisti che hanno avuto su di me un’influenza incredibile… quando sento Paolo Fresu lui è sempre costantemente più avanti di me, io penso delle cose che lui ha già realizzato. Oppure Rava, quella capacità poetica che c’ha… ogni concerto tira fuori sempre delle cose che dici: “Ma guarda dove è andato…”. Sempre qualcosa che non ti aspetti. Però il jazz permette, comunque, di avere questa cosa. Ecco, quando senti qualcuno così, io non mi sento meno, mi sento che ho voglia di suonare. Sento che ho voglia di prendere la tromba, andare a casa e mettermi giù.
Ti senti ispirato.
Esatto.
Nient’affatto invidioso?
No. No. E dopo c’è qualcuno che non riesco proprio ad avvicinare… forse Wynton Marsalis. Per certe cose anche Dizzy Gillespie. Freddie Hubbard… sono strumentisti che hanno una tecnica clamorosa che io non ho. Però ognuno nel jazz mette quello che sa fare, e adegua il pensiero a quello che sa fare. Quando sento queste cose io ho voglia di prendere la tromba.
Probabilmente le persone che frequenti amano tutte questo genere musicale, il jazz. Tra quelle che frequento io invece c’è proprio chi non lo sopporta. C’è qualcosa da capire nel jazz che sfugge ad alcuni? E poi: è vero che in generale le donne non lo amano o è solo una cosa che piace ripetere a un “mio amico”?
(Ride). Credo di conoscere quel tuo amico. Quando ho sentito questa cosa in una canzone di Paolo Conte, da adolescente, sono stato abbastanza colpito e ho pensato: qua butta male, allora. Ma non ho abbandonato il jazz lo stesso.
(Ridiamo, dopodiché mi chiede di ripetergli la domanda).
La cosa da capire è un po’ quello che ho detto prima. Si sviluppa in modo un po’ diverso, il jazz. E quindi se tu entri in questo meccanismo capisci che è una cosa meravigliosa: è ascoltare un dialogo. La musica è un pensiero, una capacità del nostro cervello di pensare. Noi pensiamo parole e pensiamo suoni. E riusciamo con la musica meglio che con le parole – a meno che non si è uno scrittore, riusciamo a tirare fuori i nostri sentimenti meglio che con le parole. Un accordo minore ti fa capire immediatamente che c’è un senso di tristezza.
Con i ragazzi cui insegno molte volte faccio un giochino per fargli capire gli accordi; gli chiedo: “Com’è andata con questa ragazza con cui sei uscito, ieri sera?”. Poi, prima che risponda, faccio un accordo minore e tutti si mettono a ridere, perché immediatamente capisci che qualcosa non è andato. Non c’è un perché, ma i suoni si collegano alle nostre emozioni, al nostro sentire, in modo diretto, e noi li comunichiamo. E abbiamo questo beneficio sia che facciamo musica sia che la ascoltiamo. Certa musica ci culla, magari perché in quel momento abbiamo bisogno di quel tipo di suono, che sia triste o allegro. Il musicista è anche un catalizzatore di quello che accade in quel momento. Lo capisce dal silenzio del pubblico, lo capisce da alcuni movimenti, dagli sguardi…
Capisce come il pubblico sta ricevendo ciò che sta suonando?
Esatto. Esatto. Capisce di che cosa c’è bisogno in quel momento. E se non lo fa il solista magari lo fa il batterista, e se non lo fa lui lo fa il bassista. Questo nel jazz è possibile.
Quindi a partire da un canovaccio uno lo modula a seconda degli umori che percepisce intorno a sé nella sala?
Questo è, come dire, quello che deve accadere. Non sempre accade questo. Quando il jazz viene suonato andando dietro ai linguaggi, con tutti gli stilemi, la grammatica precisa della cosa e però senza il patos giusto, allora… c’è poco da ascoltare.
Questa è una domanda tendenziosa, ti avviso. Nel tuo disco Voyage c’è un brano che s’intitola “Speriamo che passi”. Forse non è incoraggiante come l’ “Andrà tutto bene” al quale molti italiani si sono affidati durante i periodi difficili che abbiamo vissuto, ma questo sperare, augurarsi che qualcosa passi ha in sé, come nel ritmo del tuo brano, qualcosa di ancora inconsolato che si muove, tra alti e bassi, verso una risoluzione consapevole e non perentoria. La speranza è in parte agita, l’andrà bene è una previsione ottimistica. La contingenza attuale non c’entra con il tuo brano che fa parte di un disco del 2001, però quello era il principio di un millennio che è stato scosso da molte catastrofi. Stiamo ancora sperando che passi o è venuta meno anche la speranza?
Quel brano non è mio, è di Emilio Marinelli, il pianista, che si era lasciato con la ragazza, e dietro c’era tutta la sua sofferenza. Detto questo, il mondo è in evoluzione. Non c’è qualche cosa che ritorna. Non c’è. È impossibile. E quindi si tratta di capire cosa c’è adesso e che cosa ci sarà domani. La percezione dei musicisti non è una bella percezione in questo momento. Per tanti motivi. Un po’ per quello che ti ho detto prima: la musica è un pensiero, è una capacità del nostro cervello, se non reagiamo il nostro cervello perde delle capacità, si adatta. Se non facciamo i conti a mente ma solo con la calcolatrice del telefono, perdiamo la capacità di fare i conti.
Con la musica è la stessa cosa. Al momento noi musicisti abbiamo tantissimi problemi… Uno è il problema della qualità dell’ascolto. L’ascolto dal telefono, dal computer, vuol dire avere molte meno informazioni, alcuni strumenti non si sentono. Il suono non è completo, il basso non si sente. A meno che non ci siano dei software particolari ti mancano delle informazioni importanti e quindi non riesci a collegare ciò che ti arriva a delle emozioni. L’altra cosa è che si sta perdendo l’abitudine di andare a sentire la musica dal vivo. E questo è molto grave perché nella musica dal vivo c’è un contatto vitale. Non è tutta colpa del pubblico – io da musicista mi do una parte di colpa.
Quale?
Vuol dire che non sono riuscito a intercettare le emozioni. Non sono stato capace di creare quel suono che potesse essere recepito e fatto proprio dal pubblico.
Però è anche vero che il jazz è un genere colto, no? Ha un certo tipo di pubblico.
Non è un genere colto, no. Secondo me è per tutti. Però è un problema di linguaggio, e lì la colpa è dei musicisti. Il jazz è sempre stato un linguaggio che rappresentava qualche cosa. Non nasce solo dai neri in America, nasce dagli immigrati. Noi italiani abbiamo portato delle cose, i francesi altre, gli inglesi, gli spagnoli, e poi chiaramente gli africani. Ognuno ha portato qualcosa. Il jazz era per molti la musica della speranza. Chi ha portato gli strumenti, chi la conoscenza musicale… gli africani hanno portato la parte ritmica. Si sono inventati il blues, che è la musica più triste che possa esistere, e chiaramente solo loro che sono stati schiavi la potevano inventare. Noi italiani abbiamo portato la parte della speranza, la parte di quelli che partivano con solo una valigia di cartone in cerca di fortuna in America.
Quello è stato il primo colloquio, quindi, tra diverse etnie.
Sì. Lo swing, una forma particolare di stare nel tempo, nasce negli anni venti. Era una musica che si ballava. Nascono le grandi orchestre. Negli anni quaranta si è voluto dare un taglio, perché molti non si riconoscevano più in quel modo anche bianco di portare la musica. E quindi si è evoluto un linguaggio che era incomprensibile per quelli che fino a un attimo prima andavano a ballare con le orchestre swing. Gli stessi musicisti poi si ritrovano di notte, in locali, a suonare un linguaggio completamente diverso, meno melodico, più frammentato, che rappresentava proprio la voglia di tagliare con la musica precedente.
La stessa storia del jazz la puoi leggere nella storia della musica del novecento. Quando è nato il rock a quel punto è cambiato anche il jazz. È cambiato il sentire delle generazioni attraverso i movimenti sociali che si sono succeduti. Ho spesso delle discussioni con altri musicisti su questo argomento: il jazz non va confuso con il linguaggio. Il linguaggio è del momento – il bebop è degli anni quaranta, nei cinquanta già non c’era più. Il free jazz era un momento di grande rottura, negli anni settanta ci sono stati concerti da quattromila persone. Adesso non può essere più, non siamo più così. La musica è cambiata tanto, noi siamo cambiati tanto.
Tra poco ci saranno i seminari da te coordinati di Arcevia Jazz Feast, e quest’anno, nel saggio finale, si registreranno dei brani che saranno poi riversati in vinile, accompagnati da testi scritti per l’occasione basati sulle “Storie del Museo”. Il museo in questione è quello Archeologico di Arcevia. Si ha l’impressione che tu stia costruendo dei ponti tra un remotissimo passato e il presente, oggi un po’ incerto e zoppicante. Un’operazione culturale in cui diversi saperi si uniscono e suonano insieme come una band. Che cosa ti piacerebbe che venisse fuori tra queste connessioni?
Un nuovo linguaggio. In realtà a me non piace fare le cose carine. Non… non penso mai di fare una cosa carina. Io voglio fare qualche cosa che lasci un’emozione alle persone. Per fare questo serve la collaborazione di più linguaggi, in questo momento. La musica da sola fa fatica. E mettendo insieme più linguaggi potremmo aprire più porte, come dire… scavare un po’ di più. Quest’anno ad Arcevia ci saranno diverse cose nuove. Una registrazione dei gruppi di musica d’insieme, dal vivo, e poi un’altra registrazione di diverso genere, al chiostro di San Francesco, in cui dei jazzisti musicheranno testi scritti per l’occasione da alcuni scrittori. E poi c’è una borsa di studio per la produzione di un disco che andrà a uno dei partecipanti del seminario. Quindi abbiamo lavorato molto, anche se costretti dalle normative sulla sicurezza che stanno uccidendo la musica come forma d’arte, davvero la stanno uccidendo. Per questo andiamo verso laregistrazione come baluardo.
Perché in vinile? Mi sembra un po’ in contrasto con quanto hai detto a proposito della ricerca di un nuovo linguaggio che arrivi a più persone possibili. Non è anacronistico, il vinile?
No, perché il vinile è innanzitutto un supporto che è stato preziosissimo per la musica. È l’unica cosa che può durare nel tempo. Quando la sonda Pioneer ha superato il sistema solare per andarsene a spasso nello spazio alla ricerca di altre forme di vita, la NASA ci ha messo dentro un vinile d’oro che contiene i suoni della terra, musica compresa. Perché rimane nel tempo. Se tu non hai un lettore lo puoi ascoltare con una puntina e un rotolo di carta… non è amplificato se non dal cono di carta però lo puoi ascoltare anche così. Il CD non rimane nel tempo, si rovina. E basta una tempesta solare per cancellare tutta la musica che ascoltiamo in digitale. Perdiamo completamente dati, scritti, file, musiche, li perdiamo completamente. Se qualcuno tra cinquemila anni scaverà ad Arcevia magari troverà il nostro vinile.
C’è una battuta, in Novecento di Alessandro Baricco, in cui qualcuno dice: “Se non sai cos’è, allora è jazz”. Condividi?
Sì, un po’ è vero.
Mi torna in mente l’immagine di te bambino che interrompi il gioco per togliere il disco di Art Farmer quando partono gli assolo… Non sapevi cos’era.
Esatto. Anche perché il jazz non è la sola riproposizione di linguaggi collegati a momenti storici. Tu ci senti qualcosa di familiare. È qualcosa che non sei abituato ad ascoltare ma ti arriva familiare.
Non hai risposto alla domanda di prima: è vero che alle donne non piace il jazz?
No, non credo sia vero. Sarebbe da approfondire questa cosa. Le donne hanno un sentire molto particolare, molto sottile. Ieri sera, a Pescara, era pieno di donne, ragazze, tante… non ho questa percezione. Ma sai una cosa, invece? Il mondo della musica è un mondo maschile. Al di là delle cantanti che stanno sotto i riflettori, dalle band ai produttori sono tutti uomini. Se uno pensa a una donna che fa musica pensa a una cantante, non pensa, che so, alla pianista Martha Argerich o alla trombettista Ingrid Jensen, che nessuno conosce, o Maria Schneider, omonima dell’attrice, compositrice e direttrice d’orchestra favolosa.
Il momento esatto in cui hai capito che volevi dedicare la tua vita alla musica, se ce n’è uno.
È una questione che mi pongo tutti i giorni. Come l’amore per un’altra persona, ogni giorno va alimentato. Quando prendo lo strumento e faccio una nota che mi rappresenta. Quando ascolto qualcosa. Quando penso agli esercizi da far fare ai miei studenti. È in questi momenti che si rinnova la scintilla. “Cavolo”, penso (schiocca le mani una sull’altra) “bello questo!”. Non c’è un momento. Devi rinnovare la promessa ogni giorno.

























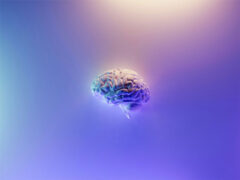
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!