La fotografia si fa arte, ricordando Mario Giacomelli
Il ricordo, artistico e affettivo, del grande fotografo di Senigallia da parte di Enzo Carli

La fotografia si fa arte, ricordando Mario Giacomelli.
L’artista indipendentemente dal tipo di pratica che esercita, porta l’arte dentro di se. Senigallia, “la città della fotografia” deve molto al grande Maestro.
La mia storia e quella di tanti altri Senigalliesi nasce con Giacomelli grande e indimenticabile artista di cui ancora oggi poco si parla; dell’indimenticabile lezione che ci ha lasciato in fotografia. Giacomelli, memore del suo Maestro, Giuseppe Cavalli non solo trascendeva la realtà ma si inventava universi sconosciuti, si spingeva nelle strade della poesia del fantastico, dell’immaginario, del ricordo e della memoria con estrema attenzione alla forma e al contenuto delle immagini. Scanno non è (solo) la testimonianza del grande realismo italiano alle prese con la questione meridionale, ma una saga epica, una storia d’amore per le proprie origini, una favola dell’esistenza.
Mario Giacomelli ha lavorato sul paesaggio come opera aperta; le immagini della sua terra, con i segni, le radiografie , la sua lirica sono tra le più alte testimonianze della fotografia del Novecento. Lavorare sul paesaggio, sulle saghe contadine nei luoghi scelti dal Maestro per riscoprire l’essenza della fotografia la sua forma, la sua bellezza e le sue performances. Immagini antropologiche in cui in ogni frammento, in ogni forma tangibile è celata la dimensione dell’uomo, dei cicli della natura e della madre terra-la Cibele di Attis-nelle tracce di significati nascosti, spesso inafferrabili ma sempre presenti. Luoghi della memoria, legati al sentimento di identità e quindi dall’esplorazione del tempo e e cogliere nel ricordo, la permanenza del sentimento
Sosteneva il grande fotografo e critico Paolo Monti, guida spirituale della Gondola, l’ecole de venice:”Guardando lentamente le sue visioni, ascoltando i suoi racconti, o scrutando criticamente i suoi stupendi paesaggi non potrei che ripetere quanto è stato già detto e arrivare alla stessa conclusione senza riserve o incertezze: Giacomelli è fra i più grandi fotografi del nostro tempo. Sono certo che Eugene Smith, forse il più grande fotografo del mondo, formerebbe volentieri molte sue fotografie di Vita d’ospizio e di un amore. Ed anche Cartier Bresson potrebbe far suoi alcuni pretini”.
Questi richiami o nomi famosi valgono a situare al giusto posto la sua opera in un ideale Museo Immaginario della fotografia mondiale; al profano che non conosce persone e situazioni, basterà consigliare un lento percorso lungo le pareti della mostra. Un viaggio dentro sé stessi. Come resistere alle sollecitazioni di queste immagini? Qui il linguaggio universale della fotografia canta in tutta la sua potenza. E davanti alle sue sequenze più belle “Un amore” e “Vita d’ospizio” ci folgora Gide: Ce ne ricorderemo di questa terra
Il critico e docente dell’École Nationale Supérieure de la Photographie di Arles, Christian Gattinoni ha sottolineato che “Giacomelli, col suo gesto espressionista che accentua i contrasti è poeta e disegnatore insieme. In realtà, la pittura e le incisioni di Alberto Burri lo toccano quanto l’opera di un Barnett Newman,a cui d’altra parte lo avvicina una certa estetica dello sviluppo delle stampe. L’utilizzazione del bianco e nero fa però tendere le sue produzioni verso l’incisione, per l’uso del nero argentato ottenuto dall’opposizione tra le diverse intensità di luce”.
Secondo Arturo Carlo Quintavalle, nel momento in cui Giacomelli organizzò il suo discorso come simbolico, sopravanzò l’estetica crociana che Giuseppe Cavalli aveva portato “a un livello superiore di gusto e di espressione, la tendenza amatoriale che fa della fotografia tanti pezzi staccati l’uno dall’altro ma aventi una funzione progressiva nel significato spirituale dell’artista” e spostò il suo messaggio verso un espressionismo fotografico che esasperava l’aspetto emotivo della realtà sottolineato dai contrasti, dai segni ed inoltre, al pari di Federico Fellini nel cinema, Mario Giacomelli capovolse completamente anche il punto di vista del neorealismo introducendo nelle immagini una nuova poesia tonale, anche onirica e realizzando racconti fotografici che si esprimevano nei racconti come nei paesaggi, escludendo inutili dettagli e che fecero di lui il più importante fotografo italiano del Novecento autonomo, a quel punto, rispetto a ogni scuola.
Mario Giacomelli, all’unanimità di critica e pubblico uno dei più altri fotografi del nostro tempo, stroncato da una grave malattia il 25 novembre 2000, cavalca nei paesaggi infiniti dell’anima.
Nato a Senigallia il 1 agosto del 1925, inizia la sua attività di fotografo la vigilia di Natale del 1952. Si regala una fotocamera Comet e si reca sulla spiaggia per fotografare il mare; per riprodurlo mosso, animato, muove la macchina. Nasce la sua prima fotografia, L’approdo, con la quale si allontana, consapevolmente, dalla tradizione della fotografia purista. La sua partecipazione al gruppo fotografico senigalliese “Misa” fondato da Giuseppe Cavalli (con Paolo Monti tra i teorici e fondatori della “nuova fotografia italiana”) permette a Giacomelli di uscire dall’ambito della piccola città di provincia per inserirsi in un panorama di ampio respiro culturale, più congeniale alle sue motivazioni ed aspirazioni. Eppure le opere più importanti del grande Maestro sono legate indissolubilmente alla sua terra: “Pur sentendomi un realista (mi ha detto Giacomelli) ho scoperto che la poesia è il linguaggio con il quale credo di poter fuggire dalle formule della banalità quotidiana. Lo spazio non è più appiattito, le cose che vedevo sempre uguali, le stesse strade, la stessa gente della mia città, pensando alla poesia, ora mi sembrano modificate, tutto sa di avventura che mi coinvolge in esperienze nuove, mi fa vivere in territori immaginari”.
Nel 1955 vince il primo premio per il miglio complesso di opere alla seconda mostra nazionale di fotografia di Castelfranco Veneto. Paolo Monti che presiede la giuria, dirà che Giacomelli è l’uomo nuovo della fotografia italiana. Nel 1957 è inserito nella prestigiosa raccolta “Photography Year Book, London” e nel 1958 in “U.S.Camera, First Edition, New-York”. Nel 1959 sulla rivista “Fotografia”, il compianto critico Giuseppe Turroni, parla già di Giacomelli prima e seconda maniera ed in occasione della mostra tenuta presso la Biblioteca comunale di Milano nel 1959, scriverà del fotografo senigalliese come del “caso” della fotografia italiana. Ma è nel 1963 che grazie a John Szarkowsky, allora curatore della fotografia al M.O.M.A. che Giacomelli si affaccia sulla ribalta internazionale con la serie Scanno (1957), prima con l’inserimento in “Looking of Photography” e poi con una sua mostra permanente nella raccolta del Museum of Modern Art di New-York. Dopo una serie di prime fotografie a titolo tra il ‘53 ed il ‘56, probabilmente influenzato dall’amico Luigi Crocenzi (tra i fondatori nel 1954 del CCF a Fermo ed uno dei teorici e sostenitori del racconto fotografico), Giacomelli affronta i grandi temi, lasciando le fotografie a titolo per i complessi di opere. Del 1954-1956 è la serie (realizzata con una Bessamatic con obiettivo Eliar color 10,5 con flash a lampadina) sulla “Vita d’ospizio”. Mario Giacomelli vive l’ospizio da quando, da piccolo, seguiva la madre che per necessità vi lavorava. La storia d’amore infinito con i vecchi dell’ospizio senigalliese sono rimandi invisibili sul filo dell’esperienza. Non a caso ci ritorna nel 1966-1968 con una serie di opere dal titolo, preso da una poesia di Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Immagini portate al limite dell’astrazione; la carne viene “bruciata” dal lampo del flash e le rughe dei volti sono le stesse della terra, le immagini rarefatte sono pervase da un profondo lirismo liciniano. Ritorna ancora nell’ospizio senigalliese con una serie senza titolo nel 1981-1983. Per nove anni dunque Giacomelli fotografa gli anziani, senza mai realizzare un reportage, senza mai l’esigenza o l’intenzione di compiere un atto di denuncia o di esprimere sdegno sociale. In un periodo in cui la fotografia è per definizione lo specchio della realtà, l’ospizio è per Mario un posto di ritrovo e di attrazione per comprendere le sue paure, esorcizzare la morte.
Soprattutto per capire il tempo, fatto da un “po’ di prima e di un po’ di dopo”, dirà Giacomelli: “Non è facile fotografare la vita d’ospizio…Quella mamma che aspetta il figlio da tre anni e che mi prende la mano quando le porto le caramelle per vederla per un attimo felice e che dice che il figlio ha tanto da fare che non può venire a trovarla…Vado all’ospizio per un mio bisogno interiore. In alcune immagini con il bianco ho tolto la materia, togliendo i particolari distruggo la realtà; le deformazioni, le sfocature tolgono il troppo vero per rimuovere la poesia. Non ho fatto belle immagini, mi sono solo nascosto in un posto che altri chiamano ospizio e che per me era un grosso specchio che permetteva di guardarmi dentro…sentivo quindi che le mie paure non erano cose inventate ma cose che io già vivevo e delle quali ero prigioniero”.
Dal 1955 fino alla fine lavora sul paesaggio della sua terra, come un’opera aperta, un capitolo fondamentale del suo lavoro d’artista ed un’eccellente chiave di lettura delle sue intime convinzioni. “Io non ritraggo paesaggi, ma i segni e la memoria dell’esistenza”. Sono tagli come le pieghe che l’uomo ha nelle sue mani, come le rughe dei vecchi dell’ospizio, come le lacerazioni della natura e dell’umanità, determinate dal flusso traumatico del tempo. Tra il 1961 ed il 1963 è la serie Io non ho mani che mi accarezzino il volto. In questa serie fantastica dei “pretini” riprese nel seminario vescovile di Senigallia, le immagini sono sospese, le tonache gonfiate come piccole mongolfiere e la trasgressione iconica di Giacomelli raggiunge il vertice dell’astrazione. Tra il 1964 ed il 1966 propone la serie dal titolo La buona terra, una saga epica, scandita dal trascorrere dei cicli, delle stagioni, caratterizzata dall’antico rituale contadino. Le immagini si sviluppano sul filo del reportage-racconto con la partecipazione di Giacomelli che dopo l’ambientazione (riprende la vita di una famiglia patriarcale nei dintorni di Senigallia) socializza con i protagonisti, li segue nei lavori dei campi e nei momenti di festa. Ancora una volta non è un documento realista di intenti politico-sociali, ma una rivisitazione del tempo, del ricordo e della memoria contadina.
Degli anni 1971-1973 è la serie Caroline Branson tratta da Spoon River Antology di Edgar Lee Master, una storia d’amore densa di significati, sostenuta da segni graffianti, da elementi naturalistici, quasi a sottolineare la drammaticità della storia, in un alternarsi di immagini suggestive, di forte impatto emozionale, “caricate” con la doppia esposizione. Anche qui, nel pretesto della storia senigalliese, ecco l’intensità della notte cosmica, del buio dei ricordi, dell’assenza/presenza dello spazio-tempo.
La fotografia di Giacomelli è quindi una trasformazione di intime convinzioni; un realismo magico filtrato dal ricordo ed intriso di poesia. Immagini come autoanalisi, come specchio dell’esistenza che attingono nei viaggi dei territori immaginari dei suoi spazi interiori. La fotografia è per lui una rievocazione di interessi che spaziano, nella sua terra, nei cicli e nelle stagioni della vita e della comunicazione. Sono reticoli di memorie, riporti quasi invisibili del suo universo mentale che gli permettono di vivere nelle pieghe della materia e in un reale immaginario, la gioia della creazione e della conoscenza. Giacomelli affronta con la fotografia temi gravi ed inquietanti e li riporta carichi di poesia, nella loro dignità originaria, senza dogmi ideologici o stilemi accademici. Rifugge dalle presunzioni, abbastanza usuali tra gli artisti contemporanei; sa che il dovere di ogni ricerca è di ritrovare l’autenticità di un rapporto con i vari aspetti della vita, conoscere i legami tra le forme espressive e recuperare l’influenza del nostro patrimonio e della nostra origine. Subisce la desolata impotenza dell’uomo di fronte alla deformità e al male; i suoi segni fotografici trasmettono queste sensazioni. Con immagini accentuate dai contrasti luminosi, dagli sfocati, dagli ingrandimenti della grana, intende superare l’angoscia del dolore e della solitudine per trasmetterci sempre un messaggio di speranza. “ […] Mi interessa la gioia che ho provato nel momento in cui ho scattato, la tensione che ho avuto di fronte all’immagine. Ecco, da quel momento (sostiene Giacomelli), l’immagine non muore più, rimane dopo la mia morte…Vorrei fuggire da questa realtà ed entrare in quella inutile della poesia”.
Chi scrive è stato per tanti anni suo affettuoso allievo ed amico; la sua grande pazienza, premurosa attenzione e sincera disponibilità mi hanno permesso di “entrare” nel suo reale immaginario, comprendere il suo viaggio interiore, là dove la morte non ha più dominio.
Da
Enzo Carli














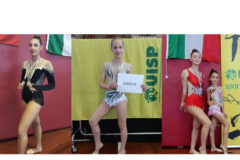











Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!